Cultura > Narrazione > L'isola dei Sicani
NINO BELVEDERE
L'isola dei Sicani
Biografia |
|
Presentazione |
|
Prefazione |
|
Brani dell'isola dei Sicani |
|
Recensioni |
|
|
Commenti |
PDF versione inglese

Sono nato agli inizi degli anni cinquanta insieme ai componenti della cricca che vedete su questa foto d’epoca scattata da un pastore sulle montagne dell’Arcimusco.
Senza di loro, “L’Isola dei Sicani” non esisterebbe così com’è, sono i miei co-autori inconsapevoli, ma forti! Per questo motivo scrivo questa biografia collettiva.
Io sono il primo a destra, quello con attaccato a un passante dei jeans un pezzo di catena arrugginita, adesso lavoro come medico vicino Torino. Al mio fianco mentre sta gustando la ricotta c’è Sebà, alias Ing. Clemente D’Aveni che vive tra Messina e Novara ma che, se almeno una volta alla settimana non respira l’aria dell’Edificiu, viene colto da una febbre misteriosa. Al centro del gruppo Carmelo Orlando. Nel romanzo, per redimerlo, gli ho dato il nome di Angelo perché da piccolo era un diavoletto, una peste. Rimane sempre il mio Pallone d’oro. Il secondo da sinistra è Filippo, alias Nino Milici, guardatelo bene, anche adesso, tranne qualche ruga, è rimasto così: è l’immortale, l’Highlander del gruppo. Infine c’è Joe, oltre che nel romanzo, lo chiamavamo così tutti i giorni perché Salvatore Giamboi doveva partire per l’Australia.
Lui è speciale, ha scritto sei pagine del libro (grazie Joe !) e quando penso a lui lo immagino sempre che passeggia sull’Harbour Bridge nella splendida baia di Sydney.
Ma non è finita qui: in questa foto manca una persona, cioè Giovanni Puglisi, manca perché quando dovevamo partire lui era in ritardo e noi presi dalla frenesia della Missione non abbiamo aspettato, ma fa parte profondamente del gruppo, perbacco, ed è co-autore, lui un giorno mi regalò una frase, una sola frase che da sola vale un romanzo, queste le parole: - Finché vivi, splendi!
The Edificiu, the place of life
Nino Belvedere’s novel is intense and engrossing. It offers a story rich in pathos and sensitivity; it is about the mystery of a soul which walks backwards along the path of life in an attempt to regain the sensitivity and courage of past years, as well as the heart-rending memory of his friend Santino.
This novel is about the desperate and frantic search for the debris on which to start building anew. It is also about the awakening of the ancestral memory of a self-contained universe, closed in around the dusty clearing of the “Edificiu”, the place of life.
Such and thousand of other presences make this novel into a sound which is being lowered into the depths of existence in a search for one’s own linguistic, spiritual and human roots. All of this is deeply harmoniously held together by an invisible red thread which narrates stories of great social and existential interest. In the process of telling these stories, the writer lives every word of his and, through each of them, he continually discovers himself anew, until the moment when he becomes his real self, that is a spectator for what is being written.
Nino Belvedere was born in Novara di Sicilia - Messina. He has now lived and worked in the Turin province for many years.
In 1980 he plubished a collection of poems included in the anthology “Poetry on exhibition” (Poesia in esposizione) published by the Piedmont region. “The island of Sicans” is his first novel.
Versione WEB

“ Anche se in quel piccolo mondo la vita si dissolveva, ogni casa, ogni terrazzu, ogni bagliu, ogni buscion, ogni ruga, ogni visu e ogni autra cuosa ci scolpivano nell’anima un amore che mai nessuna forza avrebbe potuto strappare dal nostro petto.”
Una storia immediata e semplice, universale, densa di pathos e sensibilità, il mistero di un'anima che all’improvviso compie a ritroso il cammino degli anni per ritrovare la sincerità e il coraggio d'allora. Il risveglio della memoria ancestrale di un mondo racchiuso nello spiazzo polveroso dell'Edificiu, ma soprattutto uno scandaglio alla ricerca delle proprie origini linguistiche, umane e spirituali. Scritto nel 1993 e pubblicato nel 1996 dalle Edizioni Tracce il romanzo nasce da un incubo e con un sogno luminoso e galoppante chiude idealmente il nostro micro-novecento completando l’affresco iniziato con le novelle di Salvatore Puglisi e proseguito dal romanzo autobiografico -Oltre l’azzurro del cielo- di Concetta La Mazza.
In questa versione WEB non sarà riproposta la copia dell’originale, cambierà la colonna sonora: verranno pubblicati i brani col ritmo di una nuova musica, ri-go-ro-sa-men-te, made in Sammasi’…
A Giulia e Michele
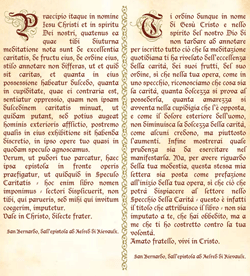 |
|---|
L’ île oubliée |

Une île. Une île sombre. Silencieuse. Une île déserte et oubliée. Sur la pauvre vallée, malheureuse et misérable, s’était abattue une dense pluie de mort : de longues montagnes basses, écrasées sous un ciel trouble ; des vagues lointaines, lointaines, et immobiles d’une mer vitrifiée. Le soleil s’était éclipsé, le soleil ne viendrait plus sur cette journée qui n’avait plus le moindre coin de ciel bleu. Des maisons délabrées et detruites, murées comme tombes n’exhalaient souffle de vie ni lueur d’existence.
Il posto era insicuro perché i nemici potevano arrivare da un momento all’altro. Le pareti della chiesa erano illuminate dalle vampate che bruciavano le case vicine e che, riflettendosi sulle tele delle nicchie, rivelavano le scene dei dipinti. Mentre cercavamo una via di uscita, da dietro la statua dell’Assunta una voce rauca e insistente c’invitava ai piedi dell’altare. Era il vecchio Ernesto che ci esortava indicandoci con la mano le cariatidi di legno, dove c’era un passaggio segreto sotto il pavimento. Con l’aiuto di Ernesto sollevammo la lastra di marmo e scendemmo la scalinata sfiorando due grandi vasche di arenaria. Dal fondo della cripta entrava un luccichio biancastro e fioco. Scorgemmo accanto ai nostri piedi i rilessi di teschi e altre ossa umane sparse sul lastricato, feretri impolverai e coperte dalle ragnatele, un corpo avvolto in un mantello nero con un berretto a tre spicchi in testa. In un angolo Sebà e Marianne s’imbatterono in una reliquia decapitata e in un’altra velata da un mantello rossastro. Dovunque nella cripta galleggiavano ombre, ombre dense e umide. Trovammo vicino alla nicchia una cassa fracida e la scoperchiammo; con sollievo scoprimmo che al fondo c’era un’apertura che rivelava una scala a chiocciola scendendo la quale e seguendo una fresca corrente d’aria ci trovammo in un altro grande sotterraneo. Sentendo il rimbombare dei nostri passi correvamo nella galleria e dopo una corsa che ci spense il fiato, arrivammo esausti a Badiavecchia nell’ipogeo del monastero. Lì ci venne incontro Leo, il cane di Ernesto, mentre in una cella, accasciati sopra una panca, ci aspettavano Filippo, Angelo e Joe; erano feriti e macchiati di sangue ma si erano salvati, mentre quella stessa notte dopo il saccheggio e la devastazione del villaggio, accanto ad un olmo sul greto della fiumara, Ulisse, Costante e altri compagni, disarmati e innocenti, erano stati trucidati tra le urla e lo strazio dei poveri contadini del luogo. |
( Questo brano è dedicato a Italo Zopolo autore di "Ulisse")
 Chiesa di Badiavecchia
Chiesa di Badiavecchia
A Badiavecchia ci nascondemmo nei sotterranei dell’abbazia. In quel luogo sacro aleggiava un profondo senso di mistero e, nonostante fossimo terrorizzati, percepivamo ancora l’aroma di quella purezza lontana e immutabile; quelle pareti, che sapevano di ceri e antichi incensi, scarne, semplici e però maestose, prive di orpelli e inutili ornamenti, custodivano, non solo i nostri miseri corpi, ma anche la nostra sete di vivere e i semi veleniferi della nostra dannazione.
Filippo aveva scovato sotto le macerie della sala capitolare un manoscritto e Marianne stava leggendo sulla pergamena quelle delicate parole; inoltre pregava e ci esortava con tenacia ad aprire il nostro cuore, a credere nella misericordia celeste.- Signore, hai disteso il cielo come un tappeto: l’hai trapuntato di stelle che ci illuminano in questa notte, mentre le belve della selva vagano e i leoni ruggiscono cercandoci come preda. Sopra il cielo hai depositato le acque, che fai poi cadere per segretissime vie sulla terra a noi tanto cara, per saziarci con frumento, vino, frutta ed olio; così noi non cerchiamo il nostro pane sudiamo invano, ma lo troviamo e ci sfamiamo, gustando, o Signore, la tua dolcezza…
Nella vastità lucente dello sguardo di Marianne serpeggiava una nube, lei sembrava avvolta in un’aura celestiale e mentre leggeva il suo viso era tornato sereno come un giorno di sole dopo la tempesta. -Finché vivi, splendi! – diceva Marianne a ognuno di noi, ma ormai le vampe dell’orrore stavano bruciando le nostre fibre svigorite e i miasmi quieti e ombrosi del peccato s’insinuavano nelle nostre menti.- La mia mente arida, sterile e infruttuosa è assetata dalle tue dolcissime acque e sospira di vedere quel pane divino che pasce gli angeli e di cui si alimenta il fanciullo. Bramo gustare nel mio intimo tutte le sue delizie. Che la tua voce risuoni al mio orecchio, o buon Gesù, affinché il mio cuore, la mia intelligenza e le profondità della mia anima imparino ad amarti: che l’intimo del mio petto ti abbracci, tu che sei il mio solo ed unico vero bene, la dolce e dilettevole mia gioia. Ma che cos’è l’amore, mio Dio?
Ernesto ci raccontò che, secondo una leggenda, seguendo tortuosi cunicoli pentagonali scavati nella roccia che perforavano la valle degli ulivi in direzione di levante, si accedeva in una doppia caverna di tufo pertugiata e buia da cui, proseguendo attraverso un meato scosceso, si giungeva a un ponte di quercia gettato sopra un crepaccio sul margine della terraferma, dove tribù di piccoli uomini, forse i primi abitatori della valle, avevano lasciato sulla pietra disegni, graffiti e rilievi, tracce indelebili di primordiali riti sacri scolpite sulle rocce di una piccola isola: da quella lingua di terra potevamo seguire le onde del mare e salvare le nostre vite con una semplice zattera di canne. Allora per giorni e giorni cercammo invano nei labirinti dell’ipogeo, ma forse quel segreto si celava in qualche cella, sopra le nostre teste, nelle parole di una salmodia cistercense assopita da secoli tra le pieghe di una pergamena, o forse dormiva dimenticato nei recessi della nostra stessa memoria.
Una mattina, stanchi d’ attendere, decidemmo di uscire dal monastero alla ricerca del cunicolo pentagonale: furtivi uscimmo dalla cripta e, appena sul transetto, di fronte alla nicchia di Sant’Ugo un brivido funesto ci attraversò le membra, subito, dubbi, timori e tremiti calarono dentro di noi. Per un attimo ci fermammo vicino all’altare nel tiepido biancore della chiesa, poi, facendoci coraggio, attraversammo cautamente la soglia del portale, sgusciammo sino al contrafforte e di corsa seguimmo il lastricato sino alla fontana; dal tubo arrugginito l’acqua gorgogliando spezzava l’angoscia di quell’inerzia sepolcrale. Quando stavamo per riempire le giarre, sentendo gemiti e lamenti provenire da un cespuglio scostammo i rami della ginestra. Nel fogliame, in una pozza insanguinata, giacevano i corpi martoriati di Ernesto e di Scila. Il cane forse era già morto.Sollevammo la testa di quel povero vecchio e dalla barba vedemmo comparire il celeste dei suoi occhi che fissavano l’ogiva del portale. Ernesto ci avvinghiò le mani, dilatò il petto, sospirò con affanno e iniziò:
Il suo volto, tirato e sofferente, s’inondò della solita luce, le sue parole muovevano l’aria. Poi qualcosa gli serrò la gola e smise di parlare. Marianne accostò alle sue labbra una pezza imbevuta nella giarra e lui si rianimò, alzò lo sguardo e poi con voce sempre più fioca riprese a parlarci.- Questa sarà la mia ultima alba, ora la mia strada incrocia quella dell’infinito e va verso la luce della saggezza…
– sto passando dalle tempeste di questa valle al quieto riposo di un porto, lascio le amarezze terrene e i beni fuggitivi del mondo per raggiungere le bianche perfezioni del cielo… l’erba non crescerà, il sole asciugherà le vostre lacrime e la notte, la notte, nasconderà il dolore. Ma io non cesso, non cessavi, non cessabo orare pro vobis
Non smetto, non ho smesso, non smetterò di pregare per voi, ci sussurrò Ernesto, ma per lui ormai s’avvicinava la fine; ebbe un brivido squassante, urlò, spalancò la bocca vomitando bava e sangue nerastro, serrò i denti, strinse in una morsa il polso di Marianne e, mentre il suo corpo sussultava, abbozzò un sorriso e col viso e gli occhi che parlavano, si liberò dal peso dell’esistenza e spirò . Dopo esserci persi nell’azzurro dei suoi occhi lo avvolgemmo nel saio con Scila e li seppellimmo insieme in una fossa tra le radiche del gelso.
 |
Senza lacrime, impietriti e sordi a ogni rumore decidemmo che era tempo di abbandonare il monastero; preparammo i nostri zaini e c’inoltrammo per un sentiero sotto la fitta boscaglia di noccioli e querce portandoci nel petto lo sguardo di Ernesto che sembrava scrutasse nel fondo della nostra coscienza, nell’effimero della nostra esistenza. Silenziosi arrancavamo tra gli ultimi bagliori delle esplosioni quando un vento turbinoso ci spinse forte sino a sollevarci e ci portò in una feritoia delle rupi sopra il paese. Sebà e Joe con la mano alzata indicarono il disco del sole che stava spuntando sulla Rocca Salvatesta; i nostri occhi piagati da tanti giorni al buio, si aprirono al fiato di quel cielo e respirammo le fresche tinte dell’alba. Quando gli ansiti nel cuore si placarono ci arrampicammo sul crinale delle rocce e ammutoliti osservammo. In quel paradiso vestito d’inferno, disgraziato, indifeso e incenerito, eravamo rimasti gli ultimi messaggeri della vita ma sembravamo delle sagome sottili animate dal vento. Con la prima pioggia sarebbe scomparsa la cenere e a primavera le ginestre, che non temono il fuoco, sarebbero rifiorite inondando la valle di un mare giallo, ma noi non riuscivamo a consolarci.
Impotenti e inutili davanti a tanta vastità desolata ci trascinammo tutto il giorno tra le pietose macerie delle case sventrate con una sete di ricordare che ci attanagliava sin dal mattino.
Anche se in quel piccolo mondo la vita si dissolveva, ogni albero, ogni terrazzo, ogni baglio, ogni ruga e ogni altro cosa ci scolpivano nell’anima un amore che nessuna forza avrebbe mai potuto strappare dal nostro petto…
o megliu: anche se in chillu parmu di tierra a vita stàggia sparinnu, ogni arberu, ogni terrazzu, ogni bagliu, ogni ruga e ogni autra cuosa signavo ‘ta nostra enima n’amuri che nessuna fuorza puia mai strazzà do nuostru pettu.
Attoniti, i nostri occhi percepivano quello stagno pietrificato dal dolore e palpitavano come quella terra bruciata, con le stesse lacrime, lo stesso sangue, la stessa fame di vita, lo stesso oscuro timore di morte e lo stesso cuore fragile, fragile e luminoso.
( A Salvatore Puglisi )
 |
Nella tarda mattinata del giorno dopo, Giuseppe e il resto della banda con gli zaini pieni si ritrovarono a Roccazza sulla scala della casa di Angelo. Dovevano esserci Alfredo, Pippo e Natalino, i quali, la sera prima sui tubi dell’’Edificiu si erano esaltati come delle scimmie ma, nel momento fatidico, i primi due si erano eclissati; forse perché non avevano ben compreso l’importanza e la delicatezza dell’operazione, o giudiziosamente avevano valutato che quella cavalcata improvvisa in quelle lande desertificate poteva essere origine di grandi avversità. D’altronde non era facile schiodarli dalle loro liturgie. Sicuramente in quel preciso istante erano stravaccati davanti al bar a giocare a tresette, sorseggiare gazzosa e a godersi l’arietta fresca che spirava nello stradone. Il povero Natalino invece pur di partecipare avrebbe spostato le montagne, ma suo padre - siccome iniziava a falciare gli sterpi - lo teneva prigioniero perché aveva bisogno di braccia. Doveva esserci anche Clemente, che a quel tempo viveva in seminario a Messina ed era magro come una sardella salata; leggeva decine e decine di libri perché da grande voleva fare il prete: se fosse partito, fragile com’era avrebbe intralciato la spedizione e indispettito i compagni che, presi dallo sconforto, avrebbero potuto anche arrostirlo sulla brace. I compagni invece valutarono con sensatezza che Clemente, abituato agli agi e ai pasti caldi del seminario, sarebbe stato una zavorra e così, presi dalla frenesia dell’avventura, anche se a malincuore, decisero di non aspettarlo.
C’erano quasi tutti gli abitanti del quartiere che seguivano la partenza e oltre alle raccomandazioni di rito offrivano olive in salamoia e passion, qualcuno pezzi di formaggio, altri mostarda di fichidindia, noci, sosizza e frutta. Donne, bambini e vecchi erano eccitati e fremevano per quella avventura. I nostri temerari esploratori, dopo la sofferta decisione di lasciare Clemente, sistemarono gli zaini sulle spalle e partirono lasciandosi indietro le ultime case del paese e Rocca Roccazza: dalla parte opposta Rocca Salvatesta e Rocca Leone, abbronzandosi al sole, parevano salutarli. I nostri, con passo felpato e testa alta, presero l’antica mulattiera pietrosa e solitaria abbandonata da anni, lungo la quale il terreno diventava sempre più brullo e rossiccio, e arrivarono nella contrada dietro le case morte. Colli aridi si ergevano da ogni parte, gli alberi si diradavano e dalla terra arsa sbucavano solo garofani selvatici, cardi giganteschi, carciofi argentati . Dalle fessure delle rocce svettavano superbe agavi verdi screziate di bianco. Dovunque però dominavano i fiori del deserto, le ginestre, e pareva d’essere entrati in un paesaggio dei fumetti di Tex Willer. Filippo fu il primo a immedesimarsi in quell’atmosfera da far west, slacciò la borraccia di zucca di suo nonno e in un italiano spericolato iniziò:-Gente, qui ci volesse un po’ di carburante: io mi ci faccio un pieno d’acqua di fuoco!
Rocce, burroni, precipizi, rocce, rocce, rocce: non si scorgeva altro: ormai quelle trazzere, anticamente percorse dai loro nonni, erano state abbandonate alle spine dei rovi e dei ginepri mentre la campagna circostante era da anni incolta, inselvatichita e solitaria. Eppure per secoli la gente della valle aveva trovato con la pastorizia e l’agricoltura un nido, una ragione di vita in quelle terre aspre, dure, difficili da coltivare, ma ormai ogni attività era cessata, non c’erano più pastori e contadini a animare quelle montagne. Infatti gli sperlinghesi o s’ammassavano sui treni che sferragliavano dal sud verso il nord dell’Europa oppure s’imbarcavano sulle navi che, seguendo rotte oceaniche, approdavano nei lontani porti delle americhe e dell’Australia. A conservare memorie di vita erano rimasti i pagliai, rifugi costruiti con pietra e frasche, gli ovili, le aie sulle quali con le cavalcature si batteva il frumento, e i muretti di sassi che delimitavano i fondi. Chissà quali sacrifici, dolori, gioie, fatiche immani e altre scene avevano visto quelle terre. I nostri avevano già percorso molta strada e intorno a loro c’era un silenzio assoluto, ma si percepiva il battito del cuore di una vita antica.
In lontananza alle loro spalle si scorgeva sbiadita, accarezzata dalle nuvole, la vetta di Rocca Salvatesta che pareva sollevare la testa per seguire la missione dei suoi valorosi figli. Sebà, con il fazzoletto intorno al collo e i lunghi capelli biondi, faceva da guida e spesso, aiutandosi con un bastone, sfoggiava la sua conoscenza:
- Ecco, ecco, su quel piano in cima al collo un tempo c’era un’aia; chissà quanto frumento ha trebbiato mia nonna.
-Scusi professor Occultis – chiese Joe a Sebà – chi lavorava quelle verdi terre vicino al torrente in fondo alla vallata?
- Semplice Joe. Mia nonna mi ha raccontato che in quella valle viveva nonna Michela con la sua numerosa famiglia. Una vedova che, con grandi sacrifici, ha portato avanti tutta la famiglia. Pensate che le restava solo un terzo dei raccolti perché doveva dare il resto ai feudatari che senza toccare una zappa si trovavano le loro case strapiene di frumento.Altri tempi, cari miei, allora…
Sembrava che Sebà avesse per anni studiato la storia del posto,o che cinquant’anni prima avesse personalmente comandato i buoi dietro l’aratro. Sapeva ogni cosa sin nei minimi particolari. Intanto la missione procedeva senza intoppi e gli esploratori con piglio intrepido attraversavano vallate solitarie, burroni e fitti noccioleti ormai deserti, ma un tempo brulicanti di contadini e pastori.
- Quella è Portella Mancina. Si chiama così perché ai tempi dei grandi latifondi ci sono morti sette braccianti in un solo giorno.
Per salari da fame facevano orari massacranti sotto un sole cocente; la forte calura li ha uccisi.
-Sebà, ma come fai a sapere tutte queste storie? – chiese impressionato Angelo.
- Mia nonna, è stata lei a raccontarmi tutto.
Dopo tutte quelle ore di viaggio sotto il sole le scorte d’acqua nelle borracce cominciavano a scarseggiare e l’arsura faceva rinsecchire la gola, ma il solito Sebà instillava gocce di coraggio agli assetati:
-Avanti debosciati, muovete le vostre zampette, ancora un piccolo sforzo e saremo premiati.
Dopo pochi minuti in quella valle silenziosa s’incominciò a percepire il dolce gorgogliare dell’acqua e improvvisamente, dopo un centinaio di metri, apparve come in un miraggio una piccola sorgente. Gli assetati di corsa si avventarono sulla vasca di arenaria e mentre Filippo danzava ringraziando gli dèi della pioggia, gli altri s’immersero coi piedi nella vasca e iniziarono a tracannare acqua sino a scoppiare.
- Laviamoci le budella! – urlavano, ma il savio Sebà li ammoniva:
-Calma, calma mammalucchi, non esagerate, altrimenti vi nascono i buffi ( le rane!) nella pancia.
Dopo essersi riempiti le pance e le borracce di acqua fresca, ripresero il cammino mentre i raggi del sole si abbassavano sempre più e sul crinale dell’altopiano si stagliavano gigantesche sagome: una a forma d’aquila pronta a spiccare il volo verso il mare e un’altra aveva l’aspetto di una figura femminile a mani giunte raccolta nella preghiera.
I nostri esploratori, spossati, cominciavano a sentire la fatica nei muscoli e sprofondavano con le scarpe nel terreno polveroso, ma più avanzavano e più aumentava la percezione d’isolamento. Non fosse stato per il fruscio del vento che spazzava l’altopiano, attorno a loro regnava il silenzio e una sensazione d’incanto alimentata dalle misteriose sagome di pietra. Soltanto le cornacchie e il lagnoso canto delle onnipresenti cicale rallegravano la loro missione.
Soltanto Joe non aveva perso il buon umore e per elevare lo spirito del gruppo sparava idiozie:
-Forza, forza fannulloni, abbiamo un appuntamento con la storia, quella con la esse maiuscola! Qui o si fa l’Italia, o si muore!
Forse lui, essendo il più robusto del gruppo, non rischiava di scoppiare, anzi allungava il passo per scrollare i compagni che resistevano come antichi guerrieri. Joe non desisteva ma Sebà, con una pacca sulle spalle, lo metteva in guardia:
- Calma, calma Joe, non sprechiamo energie, la pista è ancora tanto lunga.
 |
 |
La missione procedeva stancamente, anche Sebà non parlava più, aveva sospeso le carrellate storiche e si trascinava sudato in fondo al gruppo mordicchiandosi le labbra riarse e con lo sguardo enigmatico. Angelo avanzava a piccoli passi e supplicava:
-Se non ci fermiamo, fra poco, qualcuno ci lascia le penne! Negrieri! Quante miglia, professor Occultis, quante miglia ancora prima della gloriosa fine?
-Non starnazzare vecchia squaw – rispose con lo sguardo radioso Sebà – la meta è già nostra, ecco, ecco lassù, ci siamo, spalancate gli occhi!
In meno di un istante alzando lo sguardo fummo storditi dai riflessi celesti dei nevai perenni sui monti, i nostri monti sacri; belli, erano belli, come il giorno in cui Dio li aveva creati. La fatica svanì all’improvviso e di corsa, seguendo le grosse radiche dei cerri che serpeggiavano sul sentiero, arrivammo raggianti presso le fresche ombre di un bosco rigoglioso. La palla infuocata del sole, illuminando i torrioni di fumo che s’innalzavano dall’immenso braciere etneo, tramontava dietro i monti nebrodi: in quel nome gli attikòs migliaia di anni prima avevano scolpito i segni tangibili della loro civiltà. Infatti quando Telemaco racconta a sua madre Penelope dell’incontro con Menelao, parla di cerbiatti. Omero per indicarli usa la parola νεβρουσ.
Cerbiatti, istrici, testuggini, mustìoli, elefanti nani, cicindelidi e, secondo la leggenda ciclopi, lotofagi, lestrìgoni, scìtali, arpie e anche zazzanidi, limmi, gurpi, crasti, crabbi, muu, jinchi, bavaaggi, zagardò e trallaiti sciammiadi in ere diverse sono stati i sovrani incontrastati su quelle terre ammantate di faggi, querce, castagni e cerri giganteschi piagati dalle folgori. In tempi remoti, prima della comparsa dell’uomo le bocche di fuoco, galleggiando sul mare, sputavano linguate ardenti, avvampavano le acque e tuonavano con boati, fragori e scatafasci che frantumavano il cielo e risuonavano in tutte le vallate e in ogni canto. Per miliardi e centinaia di milioni di anni quei vulcani primigeni avevano vomitato bava incandescente, ma per soli duecento i nostri esploratori non avevano potuto vederli; da due secoli appena, infatti, il cono di fuoco russava. Peccato, se in quel luogo fossero arrivati appena un migliaio di secoli prima, i loro ingenui occhi insieme a quelli spaventosi degli ultimi criptosauri sopravvissuti alla glaciazione della Terra avrebbero potuto vedere emergere dalle acque del mare il parto arroventato della neonata isola dei Sicani.
Poco distante dal bosco, proprio in cima all’altopiano, allineati secondo i cicli delle fasi lunari si ergevano ciclopici templi di pietra, svettanti e padroni del cielo. Levigati dai venti e dalle piogge, indistruttibili e immortali, i dolmen megalitici erano intenti a scrutare l’universo, ultimi testimoni muti di una stazione paleolitica. Tracce di esistenza umana erano rimaste scolpite in modo indelebile nel corpo della pietra bianca. In quegli antri erano stati dissotterrati ciottoli scheggiati, scaglie di litòfoni, amìgdale, crisòliti prismatici, mappe astrali e frammenti di stele antropomorfe raffiguranti scene di vita che risalivano a millenni prima di Gesù Cristo. Quel luogo sacro suscitava reminiscenze di primitivi culti litolàtrici con cerimonie orgiastiche, danze e canti propiziatori, sacrifici animali e umani e altre scene di vita preistorica.
 Lì migliaia di anni prima uomini in carne e ossa avevano compiuto le stesse azioni che adesso si accingevano a fare Joe e compagni. La vicenda si ripeteva: come i nostri antenati che da quel palmo di terra avevano guardato le colate dell’alveare infuocato, così noi scrutavamo quel mare, il mare dei Sicani, contemplando, con lo stesso sbigottimento, l’origine di quella briciola di mondo. Mentre il buio si addensava in ogni angolo e cercava di avvinghiarci, noi, come loro, con le frasche di ginestra e i ceppi di quercia, accendemmo un immenso falò che allontanò le tenebre e rischiarò l’intera vallata, illuminando le crepe dei dolmen coi bagliori delle vampate. Era già buio quando, seduti intorno al fuoco in quella bolla di luce, incominciammo ad arrostire la carne sulla brace. Poi, come bestie inferocite la divorammo tutta ancora al sangue e infine passammo alla provola, ai pomodori sott’olio, alle sarde, alla sosizza piccante, al formaggio, alla mostarda e ai passion, le saporose olive nere! Sbranammo tutto, ma tutto, non rimase nulla. Consumammo il resto della nottata, suonando i ciottoli e cantando a squarciagola: dovunque sull’altopiano rimbombava l’eco cupa delle nostre urla. Molto tardi, in piena notte, preparammo i giacigli con le felci secche e c’infilammo stanchi e felici sotto le pelli di pecora. Era nuda e trapuntata di stelle, quella notte. Assaporammo gli stessi brividi e le stesse emozioni che avevano provato millenni prima i nostri cari antenati.
Lì migliaia di anni prima uomini in carne e ossa avevano compiuto le stesse azioni che adesso si accingevano a fare Joe e compagni. La vicenda si ripeteva: come i nostri antenati che da quel palmo di terra avevano guardato le colate dell’alveare infuocato, così noi scrutavamo quel mare, il mare dei Sicani, contemplando, con lo stesso sbigottimento, l’origine di quella briciola di mondo. Mentre il buio si addensava in ogni angolo e cercava di avvinghiarci, noi, come loro, con le frasche di ginestra e i ceppi di quercia, accendemmo un immenso falò che allontanò le tenebre e rischiarò l’intera vallata, illuminando le crepe dei dolmen coi bagliori delle vampate. Era già buio quando, seduti intorno al fuoco in quella bolla di luce, incominciammo ad arrostire la carne sulla brace. Poi, come bestie inferocite la divorammo tutta ancora al sangue e infine passammo alla provola, ai pomodori sott’olio, alle sarde, alla sosizza piccante, al formaggio, alla mostarda e ai passion, le saporose olive nere! Sbranammo tutto, ma tutto, non rimase nulla. Consumammo il resto della nottata, suonando i ciottoli e cantando a squarciagola: dovunque sull’altopiano rimbombava l’eco cupa delle nostre urla. Molto tardi, in piena notte, preparammo i giacigli con le felci secche e c’infilammo stanchi e felici sotto le pelli di pecora. Era nuda e trapuntata di stelle, quella notte. Assaporammo gli stessi brividi e le stesse emozioni che avevano provato millenni prima i nostri cari antenati.
Scarica in formato PDF
i commenti del romanzo >>>

